Ripensando ai commenti che avevano accompagnato l’uscita del film “Alba rossa” nel pieno dei reganiani Anni ’80, mi viene subito in mente l’accusa di fascismo con cui il film era stato bollato e che in qualche modo ancora lo perseguita.
Ma è davvero così? Il regista John Milius certamente non ha mai eccepito a questa etichetta, ma accanto a film che sbrigativamente, e molto superficialmente, erano stati definiti “di destra” cui aveva lavorato come regista o sceneggiatore (“Conan il barbaro”, un paio di “Callaghan”), scopriamo nella sua filmografia vere e proprie perle della New Hollywood come “Apocalypse now” e “1941 – Allarme a Hollywood”, universalmente riconosciuti come manifesti assoluti del cinema progressista. E pensando alla paranoia da invasione, è proprio nel film di Spielberg che si intravedono i germi parodistici di quello che 5 anni dopo Milius avrebbe descritto in “Red dawn” in forma fantapolitica e retorica.

E se “Alba rossa” fosse dunque uno dei più riusciti e allegorici attacchi dall’interno alla storia americana? Un’autocritica delle basi stesse su cui si fonda una delle più orgogliose democrazie del mondo? Alcuni indizi, specie nella prima parte del film, parlano chiaro. La vicenda è ambientata a Calumet, un paese del Colorado con tanto di statua armata di Theodore Roosvelt che nel 1908 aveva respinto una ribellione degli Indiani d’America relegati in un area delle montagne sovrastanti. In un’altra inquadratura un tabellone in legno indica l’ultimo risultato della squadra di football, sconfitta dai “Visitors”, quasi che il destino dei locali fosse già preannunciato. Uno dei protagonisti lavora alla pompa di benzina, un distributore Chevron, il cui simbolo campeggia sulla cittadina fin dalle primissime inquadrature e il primo attacco improvviso dei paracadutisti sovietici avviene nei pressi della “Calumet High School”. Tutto normale, almeno in apparenza, ma molti segni denotano che non è proprio come sembra. La popolazione locale infatti viene rappresentata come quella nativa (“native” è l’adesivo appiccicato sull’auto dei fuggiaschi) in contrapposizione agli invasori (giubbe rosse invece che blu) che sembrano quasi provenire da un altro mondo. In pratica, un chiaro rovesciamento di ruoli che vede negli indigeni l’evidente rappresentazione degli Indiani d’America aggrediti senza tante storie da un esercito straniero, molto meglio armato, cinico e con poca voglia di trattare. La storia recente americana si ripropone in negativo dunque, con i buoni al posto dei cattivi e viceversa; e i segni in tal senso si moltiplicano con il procedere del film, a scanso di equivoci verrebbe da dire.
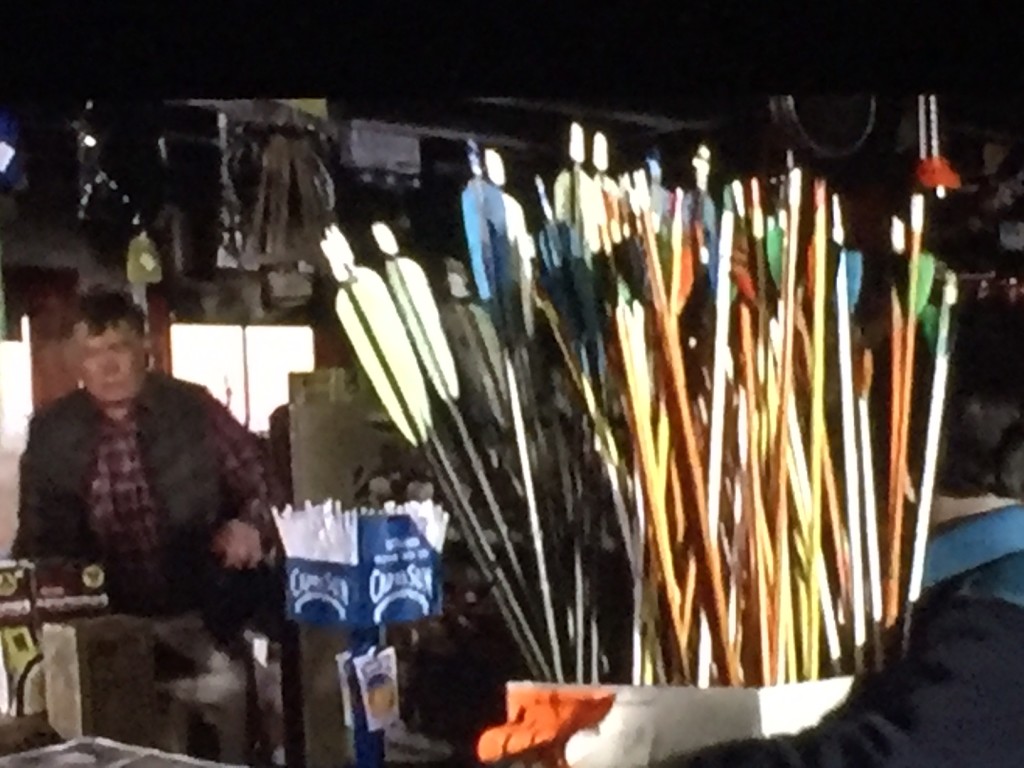
Al di là del fatto che il nome stesso del paese “Calumet”, rimanda a un chiaro simbolo di pace indiano, il gruppetto di ribelli che si ritira sulla montagna a combattere con azioni di resistenza armata si trasforma progressivamente in una vera e propria compagine di Indiani della tribù dei Piedi Neri. Sono essi stessi a dichiararlo esplicitamente, procacciandosi il cibo secondo quanto scritto nei loro libri sacri; e perfino a ripeterne i rituali propiziatori, come bere il sangue degli animali appena cacciati per catturarne anche lo spirito. Prima di ritirarsi sulle montagne (sito in cui la battaglia contro i nativi del 1908 durò analogamente un intero inverno), i nostri eroi fanno rifornimento di cibo e armi in un drugstore: zuppa Campbell’s e Coca Cola tra gli alimenti preferiti (chiaro segno di appartenenza alla Nazione americana) ma anche archi e frecce con cui si apprestano a combattere per i mesi a seguire.  Ma non basta. Il motivo dello “chevron”, due triangoli sovrapposti, celebre logo dell’azienda sorella petrolifera americana, è anche un tipico simbolo indiano. Come dicevamo, uno dei protagonisti (interpretato da Charlie Sheen) vi lavora, e il suo giubbotto ricorda quello di un capo di vestiario indiano. E anche una delle protagoniste indossa un maglione che riprende esattamente il motivo dello zigzag ripetuto all’infinito, simbolo che in antichità rappresentava i cicli della vita, a partire dal movimento della Luna che si ripeteva alternandosi nei cieli rispetto allo stesso punto di osservazione. Dunque, le fasi che si ripetono sottolineano ancora una volta come la storia cui stiamo assistendo sia in realtà un deja vu, un ciclo vichiano di eterno ritorno dove il bene spesso si confonde con il suo opposto e in cui il blu e il rosso (dai Nordisti ai Sovietici) si alternano nei secoli senza sostanziali differenze. Per rendere ancor più evidente lo stacco tra “cappelli” neri e bianchi, non mancano neppure le allusioni “naziste” agli invasori. Esiste un vero e proprio apparato collaborazionista che appoggia l’invasore e i campi di detenzione (con tanto di reti e filo spinato) si trasformano ben presto in lager e poi in campi di sterminio. Le uccisioni di massa avvengono in fosse comuni nelle modalità ben note che la Storia ci ha riportato e una delle auto usate dai “rossi” è curiosamente un maggiolino. Può far pensare al celebre film della Disney, e -soprattutto in quegli anni- all’auto hippy per eccellenza, ma in questo caso propenderei per la sua origine primaria: uno dei più celebri modelli della Volkswagen, azienda che nacque nel 1937 per volere stesso di Adolf Hitler che aveva bisogno di fornire mezzi di locomozione a buon mercato al suo grande “popolo”…
Ma non basta. Il motivo dello “chevron”, due triangoli sovrapposti, celebre logo dell’azienda sorella petrolifera americana, è anche un tipico simbolo indiano. Come dicevamo, uno dei protagonisti (interpretato da Charlie Sheen) vi lavora, e il suo giubbotto ricorda quello di un capo di vestiario indiano. E anche una delle protagoniste indossa un maglione che riprende esattamente il motivo dello zigzag ripetuto all’infinito, simbolo che in antichità rappresentava i cicli della vita, a partire dal movimento della Luna che si ripeteva alternandosi nei cieli rispetto allo stesso punto di osservazione. Dunque, le fasi che si ripetono sottolineano ancora una volta come la storia cui stiamo assistendo sia in realtà un deja vu, un ciclo vichiano di eterno ritorno dove il bene spesso si confonde con il suo opposto e in cui il blu e il rosso (dai Nordisti ai Sovietici) si alternano nei secoli senza sostanziali differenze. Per rendere ancor più evidente lo stacco tra “cappelli” neri e bianchi, non mancano neppure le allusioni “naziste” agli invasori. Esiste un vero e proprio apparato collaborazionista che appoggia l’invasore e i campi di detenzione (con tanto di reti e filo spinato) si trasformano ben presto in lager e poi in campi di sterminio. Le uccisioni di massa avvengono in fosse comuni nelle modalità ben note che la Storia ci ha riportato e una delle auto usate dai “rossi” è curiosamente un maggiolino. Può far pensare al celebre film della Disney, e -soprattutto in quegli anni- all’auto hippy per eccellenza, ma in questo caso propenderei per la sua origine primaria: uno dei più celebri modelli della Volkswagen, azienda che nacque nel 1937 per volere stesso di Adolf Hitler che aveva bisogno di fornire mezzi di locomozione a buon mercato al suo grande “popolo”…
La sequenza più significativa a tal riguardo è la replica perfetta della tragica rincorsa di Pina (Anna Magnani) al camion di nazisti in “Roma città aperta”. In un’unica inquadratura la Storia si ripete, e anche se il neorealismo era tutt’altra cosa, la citazione non poteva essere più appropriata in un film che, a ben vedere, tanto di destra non è.

